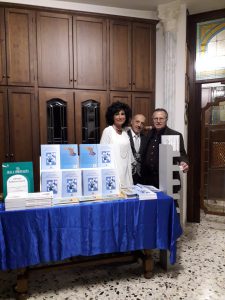Oggi, 27 gennaio, si celebra la Giornata della Memoria, che ricorda la liberazione, da parte delle Truppe dell’Armata Rossa, del lager nazista di Auschwitz e lo sterminio di sei milioni di ebrei.
Oggi, 27 gennaio, si celebra la Giornata della Memoria, che ricorda la liberazione, da parte delle Truppe dell’Armata Rossa, del lager nazista di Auschwitz e lo sterminio di sei milioni di ebrei.
La Shoah – come viene definita tale giornata – non significa in ebraico memoria, bensì desolazione, catastrofe. Essa non dovrebbe essere semplicemente una ricorrenza, per ricordare un avvenimento verificatosi in passato (sono trascorsi 73 anni da quel giorno), ma un invito a essere presenti a noi stessi, consci che nell’uomo esiste l’oscurità come la luce o meglio la mancanza di consapevolezza, che lo conduce a ignorare la luce della Conoscenza che è Verità e Libertà.
Se crediamo ingenuamente che sia sufficiente ricordare come siano stati oltraggiosi e abominevoli determinati comportamenti di chi ci ha preceduti, non diveniamo certo immuni a quelle azioni e non salvaguardiamo l’umanità da nuovi oltraggi, da nuovi abomini.
Se crediamo che il ricordo accompagnato al giudizio e alla condanna di quelle offese ci preservi dal commetterne delle nuove, trascuriamo come nella storia umana ricorra ciò di cui avremmo dovuto liberarci da molto tempo.
Non basta ricordare: la storia che trasforma gli uomini non è fatta solo di racconti e di immagini, infatti, i genocidi hanno continuato ad accompagnare l’uomo lungo il cammino. Se non vi è consapevolezza, egli non rammenta e, quindi, non apprende nulla dai propri errori.
Genocidio è una parola d’autore coniata da Raphael Lemkin, giurista polacco di origine ebraica, studioso ed esperto del massacro armeno, introdotta per la prima volta nel 1944, nel suo libro Axis Rule in Occupied Europe, opera dedicata all’Europa sotto la dominazione delle potenze dell’Asse. La concezione di Lemkin del genocidio è stata, in seguito, ampiamente accettata dalla comunità internazionale costituendo una delle basi giuridiche del processo di Norimberga.
Fra qualche anno, non vi saranno più testimoni diretti dell’Olocausto e rischieremo di ricordare soltanto date, luoghi e numeri: non vi sarà più la forza, la calda umanità, di coloro che hanno lottato, sofferto, temuto, patito, ma anche sperato.
Olocausto è composto da due parole greche: holos, che significa tutto, completo, e da kaustos, rogo, quindi possiamo tradurla con “ardere tutto”.
Nella liturgia ebraica antica, rappresentava il sacrificio levitico nel quale la vittima – che era un animale – veniva arsa completamente. Nella Bibbia, è un termine utilizzato per descrivere, appunto, sacrifici religiosi, così da rinnovare la sacra alleanza tra il Dio di Israele e il suo popolo.
Dalla seconda metà del XX secolo, Olocausto è divenuto il vocabolo per descrivere il genocidio operato dal Terzo Reich nei confronti degli “indesiderabili”: ebrei, oppositori politici, omosessuali, Rom, Sinti, testimoni di Geova, pentecostali, malati psichici, portatori di handicap, insomma, coloro che la dottrina nazista considerava diversi e di conseguenza da eliminare.
Mi pare importante fare due considerazioni: la prima è che se conosciamo e rispettiamo il significato della parola, non dovremmo più usare il termine Olocausto, poiché sarebbe come considerare quel genocidio un’offerta a Dio, un sacrificio per rinnovare la sacra alleanza. E uno sterminio non può esser questo! Nessun Dio può domandare di suggellare un patto in tal modo!
E neppure mi riconosco in ciò che affermò tempo addietro papa Benedetto XVI, il quale dinanzi all’orrore di Auschwitz si chiese dove fosse Dio, perché avesse taciuto, come avesse potuto tollerare quell’eccesso di distruzione e quel trionfo del male. Quesiti rimasti senza risposta, poiché il Papa teologo disse: «Noi non possiamo scrutare il segreto di Dio» a cui aggiunse: «dobbiamo rimanere con l’umile ma insistente grido verso Dio: Svegliati! Non dimenticare la tua creatura».
La domanda che io mi pongo è invece un’altra: non mi chiedo dove fosse Dio, quanto piuttosto dove fosse l’Uomo, quella creatura a immagine e somiglianza di Dio. Non mi domando dove Lui fosse o perché Lui abbia taciuto, perché Dio era in quel campo a donare consolazione e conforto, per cercare di lenire la shoah, la desolazione che gli uomini, con il loro libero arbitrio che, spesso è pregno di ignoranza e presunzione, avevano generato.
La seconda considerazione è che in modo silente, ma costante stiamo sviluppando nuovamente l’intolleranza verso coloro che sentiamo diversi e non mi riferisco solamente alle scritte antisemite, alle liste comparse su internet contro professionisti ebrei, alla discriminazione nei confronti degli omosessuali e dei cristiani, agli integralismi di varia matrice, ma a qualcosa di più radicato e sotterraneo, di cui poco si parla, di cui i mezzi d’informazione non raccontano, ma che spinge a discriminare chi è diverso da noi e quindi fatichiamo a comprendere, a riconoscere; chi talvolta è più fragile e vulnerabile e quindi spinge, come affermazione di potenza e di potere, a esercitare forza, anziché compassione e accoglienza.
I semi dell’intolleranza, del giudizio e dell’integralismo sono nell’uomo e a ciò dobbiamo porre attenzione, poiché è sufficiente bagnarli e questi iniziano a germogliare, soprattutto, in un tempo come il nostro nel quale la paura, il disorientamento, la confusione, la frustrazione, la rabbia e l’eccessivo individualismo sono ormai presenti nel quotidiano.
Oggi probabilmente vedremo scorrere immagini e sentiremo racconti di quello che viene definito l’Olocausto, di quel terribile genocidio, ma quanti ce ne sono stati e quanti rischiano di essercene se non prendiamo profondamente coscienza di taluni aspetti che alimentano le nostre ombre interiori?
Le mani grondanti di sangue sono state molte, anche se alcune storie vengono rammentate più di altre. È forse meno importante il genocidio armeno? Non inquietano i 48 milioni di cinesi caduti sotto il regime di Mao tra il “grande salto in avanti”, le purghe, la rivoluzione culturale e i campi di lavoro forzato, dal 1949 al 1975? O forse sono troppo lontane le storie dei curdi o dei 100 giorni in Ruanda dove sono stati uccisi con machete, bastoni chiodati e qualche arma da fuoco circa 1.000.000 di uomini? Auschwitz inquieta di più dei gulag sovietici e del terrore comunista di Stalin? Che dire del genocidio in Cambogia con il regime dei Khmer Rossi? E delle dittature militari del Sud America? E le recenti testimonianze di fede estrema o meglio di fede da sterminio, degli uomini dell’ISIS? L’elenco potrebbe continuare e, infatti, il neologismo di Lempkin è divenuto tristemente un termine ricorrente.
Quelle immagini comprensibilmente dolorose di scheletri che camminano nei campi di sterminio nazisti toccano i nostri cuori più dei campi di raccolta dei disperati che cercano di raggiungere le nostre coste, credendo che sia l’Eldorado, violati in ogni modo dai mercanti d’uomini? E tutti coloro che sono perseguitati perché considerati dissidenti da regimi che si travestono da repubbliche, ma sono ben altro? Eppure, per questioni economiche, pur inorridendo dinanzi ai genocidi, i governi cosiddetti democratici accettano e continuano diplomaticamente i rapporti, infatti, non ci inquieta veramente continuare a dialogare, per motivi politici e interessi economici, con coloro che privano della libertà uomini che la cercano per sé e per gli altri! La libertà di cui vengono privati non è solo quella del corpo, ma anche della parola, che può essere assai più rivoluzionaria, se autentica, di rivoltosi che imbracciano armi pronti a insorgere.
Spegniamo quel rogo sacrificale sul quale sono state arse tante vittime, talvolta proprio in nome di Dio: in realtà, per mettere a tacere verità non condivise o pericolose per il potere. È tutt’oggi vivo il rogo sul quale venne arso vivo Giordano Bruno, il quale non volendo abiurare venne condannato dall’Inquisizione per eresia. Mentre ascoltava inginocchiato la condanna a morte, si alzò e volgendo lo sguardo ai giudici disse loro: «Forse tremate più voi nel pronunciare questa sentenza che io nell’ascoltarla». Probabilmente, le sue parole erano così temute che il 17 febbraio 1600, quando venne condotto in piazza campo de’ Fiori, provvidero a eseguire la condanna con la lingua in giova, con la lingua serrata da una morsa affinché non potesse parlare.
Nel giorno della memoria, indigniamoci per ciò accadde per mano nazista, ma non crediamo che sia solo passato e quindi non sentiamoci presuntuosamente immuni.
Nel giorno della memoria, rammentiamo la bellezza della diversità e il valore inestimabile del rispetto della diversità tra gli uomini, che è il vero patrimonio di cui disponiamo.
Rispondiamo all’Olocausto, credendo profondamente e coerentemente alla fratellanza e alla solidarietà, che si accompagnano a condivisione e a comunione, dove Olos – Tutto – sia un modo di pensare e agire consapevole e responsabile, capace di creare interazione e integrazione.
E allora sì che potremo ardere… bruciare sul rogo l’ignoranza e l’intolleranza.
E quel rogo porterà luce, poiché sarà Conoscenza nei suoi molteplici colori: espressione sì di un sacrificio, ma non di un’offesa, non di un oltraggio. Esso così potrà divenire sacrum facere, ossia riconoscimento della sacralità delle nostre azioni quotidiane, che ci mostreranno che non siamo solo creature, ma creatori capaci di essere accoglienti, creativi, consapevoli, responsabili e compassionevoli, disposti quindi a un vero rinnovamento.
E allora guardando le immagini di repertorio nella Giornata della Memoria ricordiamo che abbiamo continuato a errare non soltanto perché bambini, donne e uomini sono stati ancora violati, assassinati, ma soprattutto perché non abbiamo ancora appreso il rispetto della libertà e il valore della dignità.
Tutto ciò non porta solo morte, ma separazione e ignoranza, infatti, come diceva colui che ha inventato il termine genocidio: «La nostra intera eredità culturale è il prodotto del contributo di tutti i popoli. Qualcosa che possiamo comprendere al meglio quando ci rendiamo conto di quanto più povera sarebbe la nostra cultura se i mal definiti popoli inferiori sottomessi dalla Germania, come per esempio gli Ebrei, non avessero avuto il permesso di creare la Bibbia o di far nascere un Einstein, uno Spinoza; se ai Polacchi non fosse stata data la possibilità di donare al Mondo un Copernico, uno Chopin, una Curie; ai Cechi un Hus, un Dvořák; ai Greci un Platone e un Socrate; ai Russi, un Tolstoj ed un Šostakovič».
A tutti coloro che difendono la Libertà e la Verità
Anna Teresa Iaccheo